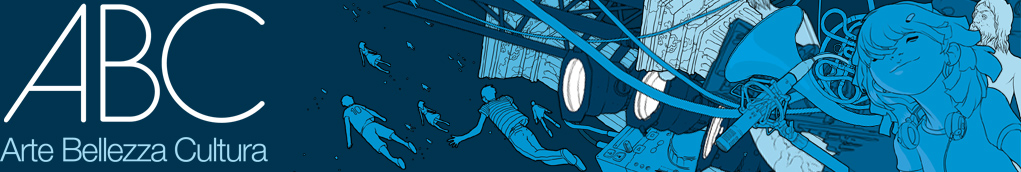Arriva in libreria una nuova edizione de La peste di Albert Camus. In previsione del Salone del Libro di Torino (14 al 18 ottobre 2021), diverse iniziative sono dedicate alle scuole e nell’ambito del programma di SalTo Scuola 2021 viene proposto il progetto Un libro, tante scuole con la distribuzione, ai docenti delle superiori che li richiederanno, di capolavori letterari in edizioni speciali. Tra questi, La peste, con una prefazione dello scrittore Alessandro Piperno, che La Lettura, il supplemento culturale del Corriere della Sera ha anticipato nell’edizione di domenica 28 febbraio. E che ci passere interessante, sotto diversi profili – storici e di attualità – riproporre all’attenzione di docenti e studenti in questa sede. Il progetto prevede inoltre una lezione di Piperno dal Teatro Argentina di Roma, martedì 2 marzo 2021, che sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma SalTo+ e su corriere.it (ore 18.45).
di Alessandro Piperno
Di norma i libri sono più intelligenti, onesti, lungimiranti di chi li scrive, e assai meno pretenziosi. Ecco perché tra i molti modi per leggere male un capolavoro letterario, il peggiore è prendere troppo seriamente i moventi morali che hanno indotto l’autore a scriverlo.
Non nego che La peste sia stata ispirata ad Albert Camus dal desiderio virtuoso, persino encomiabile, di fare i conti con la pestilenza totalitaria (fascismo, nazismo, franchismo, regimi comunisti) da cui l’Europa dell’immediato dopoguerra stava cercando di riaversi. Nei taccuini, Camus non fa che ribadirlo. «Voglio esprimere mediante la peste quel soffocamento di cui abbiamo sofferto, e quell’atmosfera di minaccia e di esilio nella quale abbiamo vissuto. Voglio contemporaneamente allargare questa interpretazione al concetto di esistenza in generale. La peste darà l’immagine di coloro che in questa guerra hanno avuto il compito della riflessione, del silenzio — e della sofferenza morale». «La peste ha un significato sociale e un significato metafisico». «La peste è un pamphlet».
Ciò che nego è che tale allegoria (sociale, universale o metafisica che sia) possa fornirci la bussola per orientarci nel putrido lazzaretto allestito — con dovizia di particolari truculenti — dal secondo romanzo di Camus. Più il lettore si convincerà che i «singolari avvenimenti» che hanno investito i cittadini di Orano non vanno presi alla lettera, ma considerati una specie di grande pomposa metafora del buio della ragione che ha travolto l’umanità, più si negherà i piaceri — complessi, non privi di spine — che solo la buona narrativa è in grado di suscitare.
Va notato, inoltre, che gli scrupoli etici di Camus rispondono a un’esigenza assai diffusa in quella generazione di scrittori (non solo francesi, ma soprattutto francesi). Gli orrori vissuti in così giovane età, il desiderio di collocarsi politicamente dalla parte giusta esecrando con quanto fiato hanno in gola quella sbagliata, li ha evidentemente persuasi che scrivere romanzi non basti. Che creare per il gusto di creare sia una diserzione. Che i narratori abbiano il dovere di edificare le masse. E che la letteratura abbia senso solo se capace di scendere in piazza e gridare, come un ambulante al mercato, le proprie verità sulla vita. D’altronde, sebbene i convincimenti politici di Camus non rivelino mai il settarismo pugnace esibito da molti suoi illustri colleghi, sono abbastanza pressanti da metterlo in crisi.
In una delle ultime conferenze all’università di Stoccolma durante le celebrazioni per il conferimento del premio Nobel, a un decennio dall’uscita della Peste e un paio di anni prima della sua morte prematura, Camus è ancora lì a tormentarsi: «Qualunque artista oggi è imbarcato sulla galera del suo tempo. Deve farsene una ragione, anche se reputa che sulla galera ci sia puzza di aringhe, che i guarda ciurma siano davvero troppi e che la rotta per giunta sia sbagliata. Sono in alto mare. L’artista come tutti quanti deve remare, senza morire se ci riesce, cioè continuando a vivere e a creare». A quanto pare, ormai, a pochi passi dalla tomba, Camus non considera più l’impegno civile come missione ineludibile, occasione di partecipazione collettiva da non sciupare, ma come una specie di vizio di cui, date le circostanze, gli scrittori della sua epoca non possono fare a meno. Ciò lo induce a rievocare nostalgicamente i bei tempi andati in cui gli artisti cantavano «per niente» e «per sé stessi». Ecco perché, conclude sconsolato, «abbiamo più giornalisti che scrittori, più boy scout della pittura che nuovi Cézanne e perché, infine, il romanzo rosa o il giallo abbiano preso il posto di Guerra e pace o della Certosa di Parma».
Non possiamo sapere quale piega avrebbero preso i princìpi estetici di Camus se fosse uscito indenne dal fatale incidente automobilistico. Ma a che serve chiederselo? Ciò che conta è ridimensionare il valore ideologico dei suoi romanzi, a vantaggio di quello artistico: La peste non è un pamphlet sui regimi totalitari che nel giro di un decennio rasero al suolo l’Europa; bensì la storia, allo stesso tempo fantasiosa e agghiacciante, di una comunità urbana dell’Algeria settentrionale che una certa mattina di primavera si è scoperta assediata da un morbo medievale.
Insomma, il consiglio che mi sento di dare al giovane lettore è lo stesso che darei a uno scrittore altrettanto acerbo: vacci piano con le metafore.
Come leggere La peste? E allora come leggere La peste, ma soprattutto come scriverne?Se qualcuno me lo avesse chiesto un anno fa avrei avuto la risposta pronta: va letta come qualsiasi altro capolavoro; con pazienza, acribia, spirito, prestando attenzione a struttura, ordito, stile, tono, movimenti tematici, personaggi… in parole povere, agli infiniti pregevoli dettagli disseminati ovunque. Sarei un ipocrita se, in nome di quest’astratto assunto estetico, non considerassi come i disagi personali prodotti dalla pandemia da Covid-19 in corso abbiano alterato, se non il giudizio, di certo il punto di vista su un romanzo che, stando al serrato intreccio e alle truci atmosfere, sembra riguardarmi (riguardarci) in un modo che non stento a definire fastidioso.
Basta considerare un passo qualunque: «Al grande slancio indomito delle prime settimane era seguito un abbattimento che sarebbe sbagliato scambiare per rassegnazione, ma che era comunque una specie di temporaneo consenso. I nostri concittadini si erano messi al passo, si erano adattati, come si suol dire, perché non c’era modo di fare altrimenti. Avevano ancora, certo, le sembianze della tragedia e della sofferenza, ma non ne sentivano più il morso. E del resto il dottor Rieux, per esempio, riteneva che fosse proprio questa la tragedia, e che l’abitudine alla disperazione è peggiore della disperazione stessa».
Come rimanere impassibili di fronte a una notazione che illustra con tale vividezza gli effetti prodotti sulla comunità dalle abitudini inflitte da un’epidemia sanguinaria? Chi di noi (e quando dico noi, parlo, non senza imbarazzo, del mondo intero) non conosce il silenzio attonito in cui si è soliti contemplare la propria impotenza di fronte a un nemico così subdolo, infido e invisibile?
D’altronde, non c’è riflessione sul morbo che in pochi mesi ha ridotto Orano a una specie di Ghost Town in cui non venga facile riconoscersi. «Dal momento che il flagello non è a misura dell’uomo, pensiamo che sia irreale, soltanto un brutto sogno che passerà. Invece non sempre il flagello passa e, di brutto sogno in brutto sogno, sono gli uomini a passare. […] I nostri concittadini non erano più colpevoli di altri, dimenticavano soltanto di essere umili e pensavano che tutto per loro fosse ancora possibile, il che presumeva che i flagelli fossero impossibili. Continuavano a fare affari, programmavano viaggi e avevano opinioni. Come avrebbero potuto pensare alla peste che sopprime il futuro, gli spostamenti e le discussioni? Si credevano liberi e nessuno sarà mai libero finché ci saranno dei flagelli».
Considerata sotto quest’ottica, non c’è dubbio che La peste si presenti al lettore odierno come un’opera spudoratamente profetica. Non c’è impulso, reazione, atteggiamento descritto da Camus che non ci sia, non solo del tutto intelligibile, ma orrendamente familiare. Non c’è smarrimento, incredulità, diffidenza, terrore da lui doviziosamente evocato che non appartenga al nostro angusto orizzonte. Per non parlare della degenerazione morale, l’ignoranza, l’ignavia, la superstizione, la rimozione, l’ottimismo, la maldicenza, il nichilismo e persino gli impulsi solidali e misericordiosi.
Stabilito ciò, mi sento tuttavia di consigliare al lettore di non lasciarsi andare a questa fuorviante e fin troppo comoda mozione degli affetti. Raramente capita di trarre dalla letteratura qualche utile insegnamento sulla vita. Avviene più di frequente il contrario: che alcune esperienze forti forniscano al lettore impressionabile una piattaforma emotiva abbastanza solida da agevolare l’immersione in un libro. È questo il caso. Leggere La peste oggi dà le vertigini. Non so nemmeno se le presenti circostanze offrano il giusto stato d’animo per affrontarla. Compulsereste Se questo è un uomo su un treno merci diretto a un campo di concentramento?
Ecco perché non bisogna dimenticare che, quando l’atroce pandemia che ci soverchia sarà venuta meno, La peste di Camus continuerà a vivere di vita propria. Eccola qui la proverbiale autonomia dell’arte, ciò che i più ottimisti arrivano a chiamare «immortalità». Tenerlo a mente significa prestare un buon servizio a Camus e al suo libro più cupo e ambizioso.
Il morbo e la passione di vivereCamus è solo l’ultimo dei malati che affollano le corsie della storia letteraria. La patologia che prese ad affliggerlo da ragazzo ha qualche vaga affinità con quella che minaccia i nostri fragili organismi: sì, insomma, di mezzo ci sono i polmoni, e quindi l’ossigeno, il respiro, la vita.
Contrasse la tisi giovanissimo in anni in cui il meglio che potevi aspettarti da malattie del genere era che si cronicizzassero. Costretto dalle circostanze a mettere una pietra sopra a sogni romantici e avventurosi, il giovane Camus conobbe il tedio e gli strazi del sanatorio.
E dire che, a differenza di molti illustri compagni di sventura (Anton Cechov, Franz Kafka, Marcel Proust, Louis-Ferdinand Céline), Camus non aveva il macilento aspetto dei malati perenni. Così lo ricorda Jean Grenier, suo mentore e scopritore: «Alto, spalle larghe, quando l’ho conosciuto, sembrava avviarsi a una carriera sportiva. Aveva, com’è naturale a quell’età, la passione del calcio. Ed ebbe sempre la passione di vivere. Di colpo si vedeva condannato a restare immobile e a prendere precauzioni, a curarsi in campagna o a medie altitudini. Cadute e ricadute si alternavano a periodi di salute. E ritornava in superficie con la stessa rapidità con cui s’era immerso e aveva rischiato di affondare, tanto forte era la sua vitalità».
Poco si capisce di Camus se non si dà giusto peso al disperato vitalismo che lo anima. Non sorprende la sua devozione a Sisifo, scalognato e atletico eroe della mitologia greca. Nel saggio che gli dedica, Camus identifica nella resistenza alla morte la sola virtù degna di nota. Ancor prima che un diritto, restare in vita è un dovere morale, un’arma per tenere testa all’assedio. «Nell’attaccamento di un uomo alla vita», scrive, «vi è qualcosa di più forte di tutte le miserie del mondo. Il giudizio del corpo vale quanto quello dello spirito, e il corpo indietreggia davanti all’annientamento. Noi prendiamo l’abitudine di vivere prima di acquistare quella di pensare».
Un atteggiamento che ritroviamo in Meursault, lo straniero, il suo eroe più celebre. Il quale avrebbe tutto il diritto di lasciarsi andare all’indolenza tipica dei temperamenti serafici e poco competitivi. E invece ama mangiare, bere, fottere, nuotare, trascorrere lunghe giornate in spiaggia. Gli piacciono le sigarette, il cinema, il café au lait. Eccolo inebriarsi dei profumi giunti dal mare in una dolce notte d’estate. Insomma Meursault, anche se lo scopre in ritardo, fuori tempo massimo, sa che cosa significa essere felici. Lo sa lui, e ancor meglio il suo creatore.
Allora si comprende perché, a dispetto di altri celebri malati, Camus non si crogioli nell’infermità, non ceda alle deliquescenze morali in cui langue l’artista decadente; perché, non ravvisando nella condizione di malato alcuna specifica nobiltà, non si lasci andare a monastiche retraite in malsani giacigli. La malattia è il male, come tale va contrastata.
Normale che a un certo punto della vita abbia sentito l’esigenza di scriverci sopra un romanzo. Fedele allo spirito tragico della sua epoca e del suo temperamento, non sceglie un morbo qualsiasi, un supplizio qualunque, bensì il flagello per antonomasia, la calamità che nell’immaginario di ciascuno di noi occupa un posto privilegiato: la peste. Con un po’ più di understatement, con maggiore sobrietà, avrebbe potuto intitolare il suo libro: Il morbo, Il contagio, L’epidemia e via dicendo. Lo intitola La peste. In tal modo conferendo al cataclisma che si abbatte sui cittadini di Orano un respiro biblico: il minimo sindacale per una città che ai vizi di Sodoma ha sostituito il filisteismo mercantile. «I nostri concittadini», scrive, «lavorano molto, ma sempre per arricchirsi. Si dedicano principalmente al commercio e pensano soprattutto, come dicono loro, a fare affari. Va da sé che apprezzano anche i piaceri semplici, amano le donne, il cinema e andare al mare. Ma, molto ragionevolmente, riservano questi svaghi al sabato sera e alla domenica mentre negli altri giorni della settimana cercano di guadagnare molto denaro. Quando la sera escono dagli uffici, si ritrovano alla solita ora nei caffè, passeggiano lungo lo stesso boulevard oppure si mettono al balcone. I desideri dei più giovani sono violenti e brevi, mentre i vizi dei più vecchi si limitano alla frequentazione delle bocciofile, delle feste del dopolavoro e dei circoli dove tentano la fortuna puntando grosso alle carte».
Orano è una città come tante, in pieno rigoglio capitalistico. I suoi abitanti, avvezzi ai disagi del clima torrido e inospitale, conducono vite ordinariamente prospere. È in questo contesto metropolitano, dopotutto banale, che il morbo si manifesta. Lo fa nel modo più disgustoso, regalando agli attoniti cittadini cupe cataste di ratti morti che sbucano da ogni tombino. Ancora una volta, venendo meno all’inflessibile ateismo, Camus infligge ai suoi eroi una piaga biblica. «Era come se la terra su cui erano piantate le nostre case si spurgasse del proprio carico di umori, lasciando affiorare bubboni e pus che finora la travagliavano internamente».
Dall’io al noiDifficile immaginare un romanzo di ispirazione più corale della Peste. Che non dipenda da tale consapevolezza lo sconforto che Camus non riusciva a smaltire anche anni dopo averlo terminato? Benché in termini commerciali e di ricezione critica gli avesse dato parecchie soddisfazioni, era scontento di questo libro. Da un certo punto di vista lo si può anche capire: è un bel rischio scrivere un romanzo collettivo, può esporti al naufragio artistico. Si pensi a un narratore ineguagliabile come Lev Tolstoj. A prima vista i suoi romanzi titanici possono dare l’illusione di parlare a nome di un’intera comunità, se non di un Paese, peraltro vasto come un continente. Non è così. Persino nelle scene-madri di Guerra e pace percepiamo i fremiti palpitanti del singolo personaggio cui Tolstoj dedica cure solerti e affettuose, dandogli cuore, corpo, voce. Un grande romanzo, anche se gestito dalla voce fuori campo del narratore onnisciente, non rinuncia mai agli afflati privati del singolo eroe. Direi che questo rappresenta la grande novità del romanzo borghese rispetto al suo glorioso antesignano: il poema epico.
Non bisogna dimenticare che quando Camus inizia a scrivere La peste è immerso fino al collo nel successo ottenuto dallo Straniero: una celebrità letteraria assai difficile da gestire (soprattutto per un ragazzo delle colonie non ancora trentenne). Camus è consapevole di aver dato vita, tramite Meursault, a una creatura dalla voce talmente fluida, felice e penetrante da essere irripetibile. Ormai possiamo dirlo: Meursault sta alla narrativa europea come Holden sta a quella americana. Difficile immaginare personaggi dal solipsismo altrettanto affascinante e contagioso. Non sorprende che ancora oggi gli adolescenti trovino così facile identificarsi sia nell’uno che nell’altro. Ecco il beffardo destino condiviso da questi due giovani sociopatici!
Ebbene, Camus vuole uscire dall’impasse con un romanzo dagli orizzonti più vasti. Sfiancato delle ubbie del disadattato Meursault, desidera affrontare i disagi della collettività. È lo spirito del dopoguerra, unito al suo umanismo solidale, a spingerlo verso questi perigliosi lidi. Forse la scelta di dedicare le sue forze creative a un’epidemia omicida deriva dal sospetto che non esista esperienza (nemmeno la trincea o il lager) che possa mettere altrettanto in crisi il sistema sociale e il conseguente rapporto tra gli individui. Da qui l’idea di conferire al nuovo romanzo un respiro corale attraverso un narratore segreto. Eh sì, perché anche La peste ha un narratore. Peccato che per conoscerne l’identità dobbiamo attendere le ultime pagine. In effetti, quando alle prime battute del romanzo ci imbattiamo nel protagonista, il dottor Bernard Rieux, non ci viene fornito alcun indizio sulla sua reale identità: non possiamo sapere che è lui l’autore del libro che abbiamo appena iniziato a leggere. Insomma, il dottore ha la delicatezza di presentarsi al lettore sotto le mentite spoglie di un personaggio. Cosa lo ha indotto a un artifizio narrativo così radicale e truffaldino? Diciamo che a reclamarlo è la natura stessa del libro. È come se Camus, sfruttando la voce dimessa del buon Rieux, il suo ritegno e senso morale, volesse levare un canto, o per meglio dire, un lamento a più voci come un coro greco. E non tanto, e non solo, per l’umanismo cui ho già fatto cenno, ma anche per due precise esigenze dal carattere diverso ma complementare: una tecnica, compositiva, e quindi stilistica, l’altra tematica.
Partirei dalla prima che è anche la più semplice da spiegare e da intendere.
Dai Taccuini emerge prepotente la necessità di Camus di conferire al suo libro una certa gelida oggettività. Il modello gli viene offerto da predecessori illustri: direi Tucidide e Daniel Defoe su tutti. Se la peste è un’esperienza collettiva, non ha senso raccontarla attraverso una narrazione intima. A pensarci, ciò spiega parecchie cose. A cominciare dallo stile della Peste che risulta asettico, se non addirittura disinfettato (lo stile di un medico, per l’appunto), in un certo senso lontano anni luce sia dai lirismi mediterranei dei primi mirabili racconti di Camus (Il diritto e il rovescio, Nozze), sia dallo spietato candore messo in campo nello Straniero. Il dottor Rieux sembra voler parlare a nome di tutti gli abitanti di Orano. Non per sé stesso. Lui è tutt’al più un testimone (è lui a definirsi tale: «un testimone di buona volontà»). Per questo ricorre così spesso alla prima persona plurale. Per questo la sua prosa appare insieme impersonale e solenne. È come se l’impellenza cronachistica prendesse il sopravvento sulle esigenze romanzesche. Insomma, Camus sconta la pressante necessità di allargare il quadro fornendo punti di vista diversi. «Bisogna assolutamente che sia una relazione, una cronaca» ammonisce sé stesso nei Taccuini. Ecco perché l’intreccio è scandito da precise indicazioni temporali e atmosferiche. Ecco perché ci vengono regalati ampi stralci degli appunti del povero Tarrou, il personaggio più commovente del romanzo. Ed ecco perché ricaviamo i dettagli sull’agonia di Paneloux, il prete, dalla testimonianza della vecchia che gli ha dato asilo. Rieux è intenzionato a non dirci più di quanto sappia, o di quanto abbia ricavato dalle confidenze che gli sono state fatte.
EsilioE adesso veniamo al punto più arduo. In un certo senso ne ho già parlato. Ma la questione è talmente delicata da meritare una digressione. Partirei dalla natura stessa dell’epidemia, di ogni epidemia. Ora sì che può tornare utile al lettore volenteroso sfruttare l’esperienza vertiginosa che da almeno un anno lo attanaglia. Che significa essere in balia di un morbo spietato? Diciamo che Camus se l’è chiesto parecchi anni prima che a noi toccasse viverlo. «Ciò che mi sembra caratterizzare meglio questa epoca», scrive nei Taccuini, «è la separazione. Tutti vennero separati dal resto del mondo, da coloro che amavano e dalle proprie abitudini. E in questa solitudine furono costretti, quelli che lo potevano, a meditare, gli altri a vivere come animali braccati. Insomma non c’era via di mezzo». L’intuizione di Camus è tanto semplice quanto incontestabile: la paura di ammalarsi rende chiunque più implicato con gli altri, e allo stesso tempo più separato. In effetti, questa sensazione di separatezza (che è qualcosa di più della solitudine bruta) viene continuamente tematizzata nella Peste. Per enfatizzarla Camus allontana sia Rieux che Rambert dalle rispettive donne. Ma non sono certo i soli ad avvertire lo strazio della lontananza. L’epidemia favorisce un isolamento generalizzato che agisce sulle sensibilità individuali in modo imprevedibile, per così dire esacerbandole.
«E per tutti noi — scrive Camus — il sentimento principale della nostra vita, che pure credevamo di conoscere bene (gli abitanti di Orano, l’abbiamo detto, hanno passioni semplici) assumeva un volto nuovo. Mariti e amanti che avevano la più completa fiducia nella compagna si scoprivano gelosi. Uomini che si credevano superficiali in amore riscoprivano la fedeltà. Figli che avevano vissuto accanto alla madre guardandola a stento ora mettevano tutta la loro inquietudine e il loro rimpianto in una piega del suo viso di cui li tormentava il ricordo. Quella separazione brutale, senza appello, senza un avvenire prevedibile, ci lasciava sconcertati, incapaci di reagire di fronte al ricordo della presenza ancora così vicina e già così lontana che ora occupava le nostre giornate. In realtà soffrivamo due volte — della nostra sofferenza e poi di quella che immaginavamo negli assenti, figli, moglie o amante».
È chiaro allora che gli effetti della peste vanno ben oltre il terrore del contagio e della morte. I mesi passano e la malattia, sempre più diffusa ma non meno invisibile, diventa un problema meno pressante, sostituita, per così dire, dall’orrenda trappola dell’esilio. A lungo andare, gli abitanti di Orano scoprono «la sofferenza profonda di tutti i prigionieri e di tutti gli esuli, che è quella di vivere con una memoria che non serve a niente».
A ben guardare, la questione morale posta da Camus in queste pagine palpitanti è la più antica di tutte: legata com’è agli archetipi della tragedia greca. Camus mette le ragioni dell’individuo contro quelle della società. Il dissidio che ne deriva rende strazianti anche le più squisite abitudini borghesi: «Il Natale di quell’anno fu più la festa dell’Inferno che quella del Vangelo. I negozi vuoti e senza luminarie, i cioccolatini finti o le scatole vuote nelle vetrine, i tram stracolmi di figure scure, non c’era nulla che rammentasse i Natali passati. In quella festa che un tempo accomunava tutti, ricchi e poveri, ora c’era spazio solo per rari pranzi solitari e ignobili che pochi privilegiati pagavano a peso d’oro in chissà quale sudicio retrobottega».
Che cosa insegna la pesteLa peste, come del resto tutte le opere di Camus, mescola a regola d’arte romanzo a tesi e conte philosophique. Volendo a ogni costo trovargli un antesignano illustre, il primo nome che viene in mente è Voltaire e il suo celeberrimo Candide. Come forse si sarà intuito, l’autore di questa prefazione diffida delle opere narrative che non vedono l’ora di sbatterti in faccia le idee dell’autore, smerciando, per di più a buon mercato, messaggi semplici e universali. Occorre ammettere, tuttavia, che Camus possiede il dono rarissimo di conferire ardore artistico alle sue idee sulla vita, alle passioni civili, intellettuali, ai rovelli etici. Al contrario dei suoi trattati filosofici che, sebbene apprezzatissimi dai più, mi sono sempre parsi diffusamente generici, confusi, enfatici e talvolta persino puerili, i racconti e i romanzi di Camus possiedono una grazia speciale, per certi versi classica. Si tratta di uno di quei casi di scuola in cui il genio poetico sovrasta di parecchie spanne l’intelligenza critica. Il segreto, com’è giusto che sia, è nello stile. Benché nel corso degli anni si sia un tantino arrochita, la voce di Camus ha conservato il pathos e la sensualità degli esordi. Pochi altri scrittori francesi, e non solo della sua generazione, hanno saputo amalgamare paratassi e lirismo in modo così naturale e persuasivo. Come ha ben mostrato Giacomo Debenedetti, la prosa di Camus ha un inconfondibile ritmo di fatalità. Che narrino le peripezie di un omicida, il degrado inflitto dalla pestilenza o i contorcimenti morali di un brillante avvocato parigino, i romanzi di Camus hanno il pregio di precipitare implacabilmente verso un disastro annunciato.
Nella Peste, il disastro in questione viene espresso sin dal titolo. Trattandosi di romanzo a tesi, è ovvio che sollevi alcune questioni dirimenti, sollecitando nel lettore l’ansia di giungere a una qualche provvisoria conclusione sulle cose della vita.
Per farla breve, quale insegnamento trarre dalla Peste?
Contentandosi dell’allegoria politica così cara a Camus e a molti volenterosi commentatori, la peste non sarebbe altro che il corrispettivo biologico di quel morbo che minaccia qualsiasi democrazia: l’autoritarismo totalitario. In tal modo vanno intese le ultime considerazioni di Rieux che ci ricordano come il bacillo della peste sia duro a morire. Resta per «decenni addormentato nei mobili e nella biancheria», aspettando pazientemente «nelle camere da letto, nelle cantine, nelle valigie, nei fazzoletti e nelle carte», pronto a rispuntare quando meno te l’aspetti, proprio come il fascismo. Tutto qui?
Mi pare che ci sia molto ma molto di più. E per capirlo bisogna chiamare in causa l’idolo polemico che domina l’intera speculazione di Camus, l’ateismo, e soprattutto il suo figlio legittimo: l’anticlericalismo. Ecco una cosa su cui il mite Camus non transige. Ce n’eravamo già accorti alla fine dello Straniero, quando Meursault per la prima e ultima volta alza la voce, perde le staffe, s’infuria, e tutto per cacciare il prete che cerca di estorcergli il più ipocrita pentimento cristiano.
Un’indignazione analoga sembra aleggiare sulla figura (assai più complessa e tragica, a dire il vero) di padre Paneloux. Le sue eloquenti prediche incombono sugli appestati abitanti di Orano come profezie. La tentazione oscurantista di considerare l’epidemia una punizione divina conduce questo prete a conclusioni a dir poco paradossali: curarsi è un peccato, così come resistere al morbo, bisogna lasciarsi andare alla Provvidenza, alla volontà di Dio, confidare nella Grazia.
Non bisogna conoscere così bene Camus per capire che non c’è posizione morale che lo mandi più in bestia. Per questo ateo — così affamato di piaceri semplici e naturali — niente è più scandaloso che conferire un senso al dolore che ci affligge. La peste è il castigo di Dio? Se così fosse, servirebbe a qualcosa. La vita avrebbe senso, e persino la Storia. Peccato che né l’una né l’altra ne abbiano alcuno, almeno non per Camus. Già prima di mettersi a scrivere, mentre prende appunti nei Taccuini, non vacilla: «Moralità della peste: non è servita a nulla e a nessuno. Soltanto quelli che la morte ha toccato, direttamente o nei loro congiunti, hanno imparato. Ma la verità che hanno conquistato riguarda soltanto loro. È senza avvenire».
Eccoci al dunque: quale lezione trarre dalla peste? Che cosa ci ha insegnato? A cosa è servita? A un bel niente.